In questo sesto capitolo di "Gli Uomini e le Rovine" di Julius Evola, l'Autore traccia un bellissimo quadro di come dovrebbe essere il lavoro in una società "normale", mostrando al tempo stesso quale assurdo livello di stortura e deformazione viviamo oggi, avendo reso l'economia il dio assoluto intorno al quale ogni cosa gira.
Si tratta di un testo veramente illuminante, che merita di essere letto e meditato con attenzione perchè se si vuole invertire il processo (ammesso che ormai sia possibile farlo) l'unica possibilità che abbiamo è quella di rivedere le nostre priorità.
CAPITOLO SESTO
di Gli Uomini e le Rovine, di Julius Evola
LAVORO – DEMONIA DELL’ECONOMIA
In precedenza abbiamo già fatto riferimento all’analogia esistente fra il singolo e un ente collettivo, analogia la cui legittimità è stata riconosciuta fin dalla più alta antichità. Partendo da ciò, abbiamo rilevato che nei tempi ultimi in fatto di organizzazione politico-sociale si sta scendendo dal piano di un essere in cui la parte vitale e materiale è subordinata a facoltà, forze e fini superiori, a quello di un essere nel quale questa sfera superiore manca o, ancor peggio, per via di una inversione, è destituita di ogni realtà propria ed è posta al servizio delle funzioni inferiori, a quelle corrispondenti, nel singolo, alla sua parte semplicemente fisica.
Nell’altro termine, ossia nello Stato, questa parte è costituita in genere dall’economia. E sotto questo aspetto particolare vogliamo ora considerare il fenomeno in questione.
La tesi del Sombart, secondo cui quella attuale è una era dell’economia, esprime esattamente l’indicata anomalia. Si tratta anzitutto del tipo generale di una intera civiltà. E tutti gli aspetti esteriori di potenza e di progresso tecnico-industriale della civiltà contemporanea non mutano nulla nel carattere involutivo di essa. Diciamo di più, essi ne dipendono, perché tutto questo apparente “progresso” è stato realizzato quasi esclusivamente in funzione dell’interesse economico in quanto esso ha preso la mano su ogni altro.
Oggi si può parlare senz’altro di una demonìa dell’economia, la base della quale è l’idea che nella vita sia individuale, sia collettiva, il fattore economico è quello importante, reale, decisivo, che la concentrazione di ogni valore ed interesse sul piano economico e produttivo non è l’aberrazione senza precedenti dell’uomo occidentale moderno, bensì qualche cosa di normale e di naturale, non una eventuale necessità, ma qualcosa che va accettato, voluto, sviluppato ed esaltato. Secondo quanto si è già detto, non esiste una gerarchia, o ne esiste solo una contraffazione, quando di là dal piano economico-sociale non si affermino il diritto e il primato di valori e di interessi più alti – di conseguenza, quando gli uomini e ai gruppi o corpi che questi valori, questi interessi rappresentano e difendono, non venga riconosciuta una superiore autorità.
Se così stanno le cose, già per definizione un’era economica è fondamentalmente anarchica e antigerarchica; essa rappresenta un sovvertimento dell’ordine normale. E la materializzazione e la disanimazione di tutti i domini dell’esistenza, che le sono propri, destituiscono di ogni significato superiore tutti quei problemi e quei conflitti che in essa vengono considerati come i soli importanti.
Siffatto carattere di sovversione è presentato tanto dal marxismo quanto dal suo apparente antagonista, il capitalismo moderno.
E l’assurdo peggiore è quello di chi oggi presume di rappresentare una “Destra” politica senza uscire dal circolo buio e chiuso, determinato dalla demonìa dall’economia, entro cui sia il marxismo, sia il capitalismo, insieme a tutta una serie di gradi intermedi, si muovono.
Ciò dovrebbe essere tenuto ben fermo da chi oggi si schiera contro le forze di sinistra. Nulla è più evidente che il capitalismo moderno è sovversione quanto il marxismo. Identica è la visione materialistica della vita che alla base dell’uno e dell’altro; identici qualitativamente sono gli ideali di entrambi; identiche, in entrambi, sono le premesse legate ad un mondo il centro del quale è costituito dalla tecnica, dalla scienza, dalla produzione, dal “rendimento” e dal “consumo”.
E finché si sa parlare solo di classi economiche, di profitti e di salari, di produzione, finché si crede che il vero progresso umano sia condizionato da un particolare sistema di distribuzione della ricchezza e dei beni e che, in genere, esso abbia a che fare con la ricchezza o l’indulgenza, non si sarà nemmeno sfiorato l’essenziale anche se teorie nuove, di là da marxismo e capitalismo, o come transazioni fra l’uno e l’altro, venissero escogitate.
Il punto di partenza dovrebbe invece essere la negazione recisa del principio, formulato dal marxismo, che riassume l’insieme della sovversione dianzi indicata: “La economia è il nostro destino”. Si deve affermare senza mezzi termini che tutto ciò che è economia e interesse economico come soddisfacimento dei bisogni materiali e delle appendici più o meno artificiali di essi, ha avuto, ha e sempre avrà una funzione subordinata in una umanità normale, che di là da questa sfera deve differenziarsi un ordine di valori superiori, politici, spirituali, eroici, un ordine che non conosce e nemmeno ammette classi semplicemente economiche, che non sa né di “proletari” né di “capitalisti”, un ordine, solo in funzione del quale debbono definirsi le cose per le quali vale davvero vivere e morire, deve stabilirsi una gerarchia vera, debbono differenziarsi delle dignità e, al vertice, troneggiare una superiore funzione di comando, di imperium.
Ma dove è che al giorno d’oggi si combatte in questi termini la giusta battaglia?
“Quistione sociale” e “problema politico” stanno perdendo sempre più ogni significato superiore per definirsi sulla base delle condizioni più primitive dell’esistenza fisica, condizioni che vengono assolutizzate e sciolte da ogni più alta esigenza. Il concetto di giustizia lo si riconduce all’uno o all’altro sistema di distribuzione dei beni economici, il concetto di civiltà lo si misura con poco più che con quello di produzione, di lavoro, di rendimento, di classi economiche, di salari, di proprietà privata o socializzata, di “venditori di lavoro” e di “sfruttatori dei lavoratori”, di “rivendicazioni di categoria” e via dicendo.
Per gli uni e per gli altri sembra davvero che non esista null’altro al mondo. Ossia, per il marxismo il resto esiste, sì, ma la titolo di una “sovrastruttura” e di una derivazione.
Dalla parte opposta si ha pudore per esprimersi in termini così drastici, ma, di fatto, l’orizzonte non è diverso, lo standard è sempre quello economico, l’interesse centrale è sempre la economia. Tutto ciò attesta una vera e propria patologia della civiltà. Come si è detto, è una ipotesi, una demonìa quella, che il fatto economico sta esercitando sull’uomo moderno.
E, come spesso avviene nell’ipotesi, ciò su cui la mente si focalizza finisce col divenire reale. L’uomo di oggi sta facendo divenire vero ciò che in ogni civiltà normale e completa sarebbe apparso come una aberrazione o come uno scherzo di cattivo genere – ossia appunto che l’economia e il problema sociale in funzione di economia siano un destino.
Così, a che un nuovo principio sia posto, non si tratta di opporre l’una formula economica all’altra, ma di mutare fondamentalmente attitudine, di respingere assolutamente le premesse materialistiche partendo dalle quali si è prodotta l’assolutizzazione del fatto economico. Non il valore dell’uno o dell’altro sistema economico, ma quello dell’economia in genere va posto in quistione.
Così la stessa antitesi fra capitalismo e marxismo, malgrado il suo giganteggiare sullo sfondo dei tempi nostri, va considerata come una pseudo-antitesi. Il mito della produzione con quanto ne deriva in tema di standardizzazione, di monopoli, di cartelli, di tecnocrazia e via dicendo obbedisce, nelle civiltà capitalistiche, alla stessa demonìa dell’economia e va a costituire a fattore primario le condizioni materiali dell’esistenza non meno che nel marxismo: nell’un caso come nell’altro valgono come “retrograde” o “sottosviluppate” le civiltà che non si riducono a “civiltà del lavoro e della produzione”, quelle che, per un concorso fortunato di circostanze, non sono ancora così prese nel parossismo dello sfruttamento industriale ad oltranza di ogni risorsa naturale, dell’asservimento sociale e produttivo di ogni possibilità umana, dell’esaltazione dello standard tecnico ed industriale – quelle civiltà, insomma, che conoscono ancora uno spazio e un certo libero respiro.
L’antitesi vera non è dunque quella fra capitalismo e marxismo, ma è quella esistente fra un sistema nel quale l’economia è sovrana, quale pur sia la forma che essa riveste, e un sistema nel quale essa è subordinata a fattori extraeconomici entro un ordine assai più vasto e completo, tale da conferire alla vita umana un senso profondo e da permettere lo sviluppo delle possibilità più alte di essa.
Questa è la premessa per la vera reazione restauratrice, di là sia da “destra” che da “sinistra”, sia dalla prevaricazione capitalistica che dalla sovversione marxista. La condizione a tanto è una disintossicazione interna, un ridivenire normali in senso superiore, un saper distinguere nuovamente fra ciò che è basso interesse e ciò che è superiore interesse.
Qui non vi è azione esterna che giovi; l’azione esterna potrà al massimo essere un coadiuvante. Per una rimozione, si tratta anzitutto di respingere la interpretazione “neutra” del fenomeno economico propria ad una deviata sociologia.
La stessa vita economica si compone di un corpo e di un’anima, e fattori interni morali, ne hanno sempre determinato il senso e lo spirito. Tale spirito – e il Sombart l’ha messo ben in rilievo – va distinto dalle forme di produzione, distribuzione e organizzazione dei beni, esso può variare e, a seconda dei casi, dà al fatto economico una portata e un significato del tutto diversi. Il puro homo oeconomicus è una funzione oppure è il prodotto di una evidente specializzazione degenerativa. Pertanto, in ogni civiltà normale l’uomo puramente economico, quello cioè al quale l’economia vale non come un ordine di mezzi ma come un ordine di fini tanto da costruire il dominio al quale va a consacrare le principali sue attività – valse sempre, e giustamente, come uomo di estrazione inferiore: inferiore, spiritualmente, ancor prima che socialmente o politicamente. In essenza, si tratta dunque di tornare alla normalità, ossia di ripristinare la naturale dipendenza del fenomeno economico da fattori interni, morali, e di agire su tali fattori.
Ove si riconosca ciò, si riconosceranno anche facilmente le cause interne che nel mondo attuale, avente per comun denominatore l’economia, precludono ogni soluzione che non si traduca in una sempre più grave caduta di livello. In precedenza abbiamo già detto che la sollevazione delle masse è stata in larga misura provocata dal fatto che ogni differenza sociale si è ridotta a quella propria a semplici classi economiche, dal fatto che, nel segno del liberalismo antitradizionale, la proprietà e la ricchezza, sciolte da ogni vincolo e da ogni valore superiore, sono quasi divenute le uniche basi delle differenze sociali.
Ma fuor dai limiti ristretti – dai limiti che in precedenza all’economia in genere erano fissati nell’ordine gerarchico complessivo – la superiorità e il diritto di una classe in quanto è semplicemente classe economica possono venire giustamente contestati in nome di elementari valori umani. Proprio qui doveva inserirsi però la ideologia sovversiva, assolutizzando una situazione anomala e degenerativa e facendo come se altro non fosse mai esistito e altro non possa esistere sé non classi economiche, se non superiorità e inferiorità sociali estrinseche ed ingiuste basate sulla semplice ricchezza.
Ma tutto ciò è falso, condizioni del genere verificandosi appunto e soltanto in una società tronca; solo in una tale società possono definirsi i concetti di “capitalista” e di “proletario”, concetti privi di ogni realtà in una civiltà normale perché in essa la controparte costituita da valori extraeconomici fa apparire, di massima, i tipi umani corrispondenti come tutt’altro di ciò che oggi viene designato come “capitalista” o come “proletario”, ed essa anche nel dominio dell’economia conferisce una precisa giustificazione a determinate differenze di condizione, di dignità e di funzione[1].
Va poi riconosciuto quel che nel disordine attuale è dovuto ad una inferiore ideologia. Non è tanto vero che il marxismo è sorto ed ha attecchito perché esisteva una quistione sociale reale (ciò poté verificarsi al massimo agli inizi dell’epoca industriale); vero è piuttosto che la quistione sociale in larga misura sorge, nel mondo di oggi, solo perché esiste un marxismo, ossia artificialmente, per l’opera organizzata di agitatori, dei cosiddetti “ridestatori della coscienza di classe”, circa i quali un Lenin si espresse molto chiaramente nell’insegnare al partito comunista il compito non di sostenere i movimenti dei “lavoratori” dove esistono in via naturale ma di provocarli, di suscitarli dovunque e con ogni mezzo.
Il marxismo fa nascere la mentalità proletaria e “classista” ove prima non esisteva, suscitando un’agitazione, un risentimento e una insoddisfazione là dove il singolo si teneva ancora al posto suo, conteneva entro limiti naturali il suo bisogno e le sue aspirazioni, non ambiva a divenire diverso da quello che era e proprio su tale base ignorava quella “alienazione”, quella Entfremdung messa avanti dal marxismo, il quale, peraltro, non sa superarla che con una forma assai peggiore di essa, ossia con l’ “integrazione” (cioè con la disintegrazione) della persona in un “collettivo”. Qui non si propugna in alcun modo un “oscurantismo” a tutto vantaggio delle attuali “classi superiori”, perché si è già detto che la superiorità e il diritto di una classe in quanto è semplicemente una classe economica in un mondo materialistico, noi li contestiamo.
Tuttavia si deve prender posizione contro l’idea, o mito, del cosiddetto “progresso sociale”, che è un’altra delle fissazioni patogene caratteristiche dell’era economica in genere, perché non sono le sole correnti di sinistra ad averlo in proprio.
A tale riguardo le vedute escatologiche del marxismo non differiscono, infatti, un gran che da quelle “occidentali” della prosperità: sia la visione della vita in partenza che le conseguenze sono, in fondo, le stesse. Fondamentalmente, qui torna ad affermarsi la concezione societaria antipolitica materialistica, che distacca l’ordine sociale e l’uomo da ogni ordine e fine superiore, che per unico scopo pone l’utile in senso fisico, vegetativo e terrestre e che facendo di esso il criterio del progresso inverte i valori propri ad ogni struttura tradizionale perché la legge, il senso e la ragion sufficiente di tali strutture sono sempre consistite nel riferire l’uomo a qualcosa di là da lui, economia e benessere o indigenza materiale avendo, rispetto a ciò, un’importanza subordinata.
Così si può affermare legittimamente che il cosiddetto “elevamento delle condizioni sociali” va considerato non come un bene, ma come un male, quando prezzo ne sia l’asservimento del singolo al meccanismo produttivo e al conglomerato sociale, la degradazione dello Stato in “Stato di lavoro” e della società in “società dei consumi”, la eliminazione di ogni gerarchia qualitativa, l’atrofia di ogni sensibilità spirituale e di ogni capacità “eroica” nel senso più vasto della parola. È stato scritto da Hegel che “la storia universale non è il terreno della felicità, i periodi di felicità (nel senso del benessere materiale e prosperità sociale), sono in essa, pagine bianche”.
Ma anche individualmente le qualità che in un uomo più valgono e che lo fanno veramente tale spesso si destano in un clima duro, perfino l’indigenza e d’ingiustizia, che gli costituisce una sfida, e dal quale egli viene messo spiritualmente alla prova, mentre quasi sempre intristiscono quando all’animale umano viene assicurato un massimo di vita comoda e sicura e l’equa parte di un benessere e di una felicità da bestiame bovino, che non cessano di essere tali quando ad essi facciano da controparte radio, televisione ed aerei, Hollywood e arene sportive o una cultura da Reader’s Digest.
Ripetiamolo: i valori spirituali e i gradi dell’umana perfezione non hanno a che vedere con la prosperità o non prosperità economico-sociale.
Che l’indigenza sia sempre fonte di abiezione e di vizio, e condizioni sociali “progredite”, rappresentino l’opposto, è la fola delle ideologie materialistiche, che poi si contraddicono da sé quando mettono mano all’altro mito, secondo il quale i “buoni” sarebbero tutti dalla parte del “popolo”, dei lavoratori oppressi ed indigenti, i malvagi e i viziosi tutti dalla parte delle classi ricche corrotte e sfruttatrici.
Sono una fiaba sia l’una che l’altra cosa.
La realtà è che i veri valori non hanno nessuna relazione obbligata con condizioni sociali ed economiche migliori o peggiori e che, come si è detto, solo ove quei valori siano al primo piano ci si può approssimare ad un ordine di effettiva giustizia sullo stesso piano materiale. Come valori siffatti sono peraltro da considerare l’esser sé stessi, lo stile di una impersonalità attiva, l’amore per la disciplina, una generica disposizione eroica.
L’importante è che di contro ad ogni forma di risentimento e di competizione sociale ognuno sappia riconoscere ed amare il proprio posto, quello al massimo conforme alla propria natura, riconoscendo anche così i limiti entro i quali può sviluppare le sue possibilità, dare un senso organico alla sua vita, conseguire una propria perfezione: perché un artigiano che assolve perfettamente alla sua funzione è certamente superiore ad un sovrano che scarti e non sia all’altezza della sua dignità.
È solo quando fattori del genere torneranno ad aver peso che l’una o l’altra riforma sul piano economico-sociale potrà esser studiata ed attuata senza pericolo, secondo giustizia vera, senza che l’essenziale sia scambiato con l’accessorio.
Ove, per primo, non ci si dia ad una disintossicazione ideologica e ad una rettificazione degli atteggiamenti, ogni riforma sarà solo di superficie, non toccherà le radici più profonde della crisi della società contemporanea, andrà a tutto vantaggio delle forze della sovversione. Appunto in fatto di atteggiamenti generali vale indicare quello che più di ogni altro alimenta la demonìa della economia.
Si racconta che in una terra non europea, ma di antica civiltà, una impresa americana, constatando il poco concorso degli abitanti del luogo assunti per certi lavori, pensò di aver trovato il mezzo adatto per spronarli: raddoppiò le paghe. Il risultato fu che gran parte degli operai si presentò al lavoro per la metà delle ore di prima.
Ritenendo che la mercede originaria bastava approssimativamente pei loro bisogni naturali e normali, quegli uomini giudicavano assurdo doversi applicare più di quel che, in base al nuovo criterio, occorreva per procurarsela.
Si racconta altresì che Renan, dopo la visita ad una esposizione industriale campionaria del tempo suo, se ne uscì con queste parole: “Ma quante cose vi sono di cui posso fare perfettamente a meno!”.
Si confronti ciò con quanto al giorno d’oggi è stakanovismo, “attivismo” economico e “civiltà del benessere” e dei “consumi”, con le sue applicazioni.
Meglio che da qualsiasi considerazione astratta, da tali aneddoti è data la pietra di paragone per due atteggiamenti fondamentali, da giudicarsi l’uno sano e normale, l’altro deviato e psicopatico.
Per riferirsi, al primo aneddoto, a un paese non europeo, che non si adducano i luoghi comuni circa l’inerzia o l’indolenza di razze che non sono quelle “dinamiche” e “realizzatrici” d’Occidente.
In questo, come in altri domini, contrapposizioni del genere sono artificiose e unilaterali. Basta infatti distogliersi dalla civiltà “moderna” – che del resto ormai non può dirsi più esclusivamente occidentale – per ritrovare anche da noi la stessa concezione della vita, lo stesso atteggiamento interiore, la stessa valutazione del lucro e del lavoro.
Prima dell’avvento in Europa di quella che nei manuali viene chiamata significativamente l’ “economia mercantile” (significativamente, perché ciò esprime che il tono all’intera economia fu dato esclusivamente dal tipo del mercante e del prestatore di danaro), dalla quale doveva svilupparsi rapidamente il capitalismo moderno, era criterio fondamentale dell’economia che i beni esteriori dovessero esser soggetti ad una certa misura, che il lavoro e la ricerca del profitto fossero solo giustificabili per assicurarsi una sussistenza corrispondente al proprio stato. Tale fu la concezione tomistica e, più tardi, quella luterana.
Non era diversa, anche, in genere, l’antica etica corporativa, ove avevano risalto i valori della personalità e della qualità e ove, in ogni caso, la quantità di lavoro era sempre in funzione di un livello determinato di bisogni naturali e di una specifica vocazione.
L’idea fondamentale era che il lavoro non dovesse servire per legare, ma per disimpegnare l’uomo per permettergli di seguire più degni interessi, una volta regolato ciò che è richiesto dai bisogni della esistenza.
Nessun valore economico appariva tale da meritare che ad esso si sacrificasse la propria indipendenza e che la ricerca dei mezzi per l’esistenza impegnasse oltre misura l’esistenza stessa.
Nel complesso, veniva riconosciuta la verità anzidetta, cioè che il progresso umano non deve definirsi su di un piano economico e nemmeno sociale, ma interiore, e che esso non consiste nell’uscir dai ranghi per “farsi avanti”, nel moltiplicare la quantità di lavoro per conquistarsi una posizione che non sia la propria.
Ad un più alto livello l’abstine et subistine fu una norma di saggezza che riecheggia già dal mondo classico, ed una delle possibili interpretazioni del detto dèlfico: “Nulla di troppo” potrebbe applicarsi parimenti a quest’ordine di idee.
Tutte queste, dunque, furono vedute perfettamente occidentali: dell’uomo europeo, quando era ancora sano, non ancora – diremmo così – morso dalla tarantola, non succube di un’insana agitazione che doveva pervertire ogni criterio di valore e condurre fino ai parossismi della civiltà contemporanea.
È dall’alterazione che si è effettuata a questo riguardo – dunque in sede morale, sicché tutta la responsabilità ricade senza scusa sul singolo – che si è sviluppata, attraverso processi a catena, la “demonìa dell’economia”.
Il punto di svolta è stato l’avvento di una concezione della vita che invece di mantenere i bisogni entro limiti naturali in vista di perseguimento di ciò che è veramente degno di umano sforzo, ha avuto per ideale l’accrescimento e la moltiplicazione artificiale, degli stessi bisogni, epperò anche dei mezzi per soddisfarli, senza riguardo per la schiavitù crescente che, in forza di una legge ineluttabile, ciò doveva costituire, prima pel singolo e poi per le collettività. Il limite di tale derivazione lo si ha con la situazione interna dalla quale si sono sviluppate le forme dell’alto capitalismo industriale; qui l’attività rivolta al lucro e alla produzione, da mezzo, si è fatta fine ha preso l’uomo anima e corpo e alla fine lo ha condannato ad una corsa senza sosta, ad una espansione illimitata dell’agire e del produrre, corsa imposta, perché il fermarsi, nel sistema economico in moto, significherebbe immediatamente arretrare, se non pure venire scalzati e travolti. In questo moto, che non è “attivismo” ma agitazione pura e insensata, l’economia incatena migliaia e migliaia di lavoratori non meno del grande imprenditore, del “produttore dei beni”, del “possessore dei mezzi di lavoro” e determinata azioni e reazioni concordanti generatrici di sempre più vaste distruzioni spirituali.
I retroscena del “disinteressato” amore di quell’uomo politico americano, che come formula basale del suo programma politico internazionale ha posto “l’elevamento economico delle zone meno progredite della terra”, si rilevano appunto sotto questa luce: il senso di ciò è un portare a termine le nuove invasioni barbariche – le uniche vere - , l’abbrutimento nei trivi dell’economia di parti dell’umanità ancora risparmiate dal morso della tarantola – questo, perché i capitali in crescenza cercano impiego e investimento e il meccanismo produttivo degenerato in superproduzione cerca mercati sempre più vasti.
Di ciò che Lenin ha saputo riconoscere vedendo in simili rivolgimenti uno dei tratti caratteristici del “capitalismo morente”, ossia di quello che sta scavandosi da sé la propria fossa, condannato come è dalla sua stessa legge a creare, con l’industrializzazione la proletarizzazione e l’europeizzazione, forze che alla fine reagiscono contro di esso e contro le corrispondenti nazioni di razza bianca – di ciò gli esponenti del “progresso” non si accorgono, ed è così che il processo a frana non incontra limiti.
Nei sistemi socialisti che si proclamano successori del capitalismo condannato a perire per la sua stessa contraddizione interna, l’asservimento del singolo, infatti, anziché alleviato è ribadito, ed esso non si presenta più tanto di fatto, quando di diritto: qui corrisponde ad un imperativo collettivo.
Se il grande imprenditore si dà tutto all’attività economica, facendone una specie di droga – avente per lui un’importanza vitale – per via di una autodifesa inconscia perché ove si arrestasse vedrebbe il vuoto intorno a sé, sentirebbe tutto l’orrore di un’esistenza priva di significato[2] – una situazione analoga, nelle ideologie della parte opposta, la si fa corrispondere ad una specie di imperativo etico, con la controparte di anatemi e di misure assolutamente stroncatrici per chiunque intenda sollevare la testa e riaffermare la propria libertà di fronte a tutto ciò che è lavoro, produzione, rendimento e vincolo sociale.
E qui conviene accusare un’altra delle fissazioni patogene dell’età economica, un altro dei suoi slogan fondamentali. Alludiamo alla superstizione moderna del lavoro, che è ormai propria tanto alle correnti di “destra” che a quelle di “sinistra”.
Come il “popolo”, così pure il “lavoro” è divenuto una di quelle entità sacre ed intangibili, circa le quali l’uomo moderno non osa dir nulla che non sia lode e esaltazione. Una delle caratteristiche dell’era economica secondo i suoi aspetti più squallidi e plebei è appunto questa specie di autosadismo, che consiste nel glorificare il lavoro come valore etico e dovere essenziale, e nel concepire sotto specie di lavoro qualsiasi forma di attività.
Ad una futura, più normale umanità non vi è perversione che apparirà più singolare di questa, onde, il nuovo, il mezzo si fa fine. Il lavoro cessa di significare qualcosa che si impone unicamente in vista delle necessità materiali dell’esistenza e a cui non deve esser accordato uno spazio di quel che la normalità di siffatte necessità, a seconda dell’individuo e del suo rango, lo richieda, ma lo si assolutezza appunto, sotto le specie di un valore in sé, associandolo simultaneamente al mito dell’attivismo produttivo parossistico. In più si viene ad una vera e propria inversione.
La parola “lavoro” ha sempre designato le forme più basse dell’attività umana, quelle appunto che sono condizionate più univocamente dal fattore economico. Tutto quanto non si riduce a simili forme, è illegittimo chiamarlo lavoro; la parola da usare è invece azione: azione, e non lavoro, è quella del capo, dell’esploratore, dell’asceta, dello scienziato puro, del guerriero, dell’artista, del diplomatico, del teologo, di chi pone una legge o di chi la infrange, di chi è spinto da una posizione elementare o guidato da un principio, del grande imprenditore e del grande organizzatore.
Ora, mentre ogni civiltà normale, grazie al suo orientamento verso l’alto, s’intese a dare un carattere di azione, di creazione, di “arte” perfino al lavoro (per il che, ad esempio, ci si può riferire di nuovo all’antico mondo corporativo), esattamente il contrario accade nella presente civiltà economica: perfino all’azione – a ciò che può esser rimasto di degno di tale nome – si tende a dare, oggi, un carattere di “lavoro”, quindi economico e proletario, quasi per un piacere sadico della degradazione e della contaminazione.
È così che si è giunti a formulare l’ “ideale” di uno “Stato del lavoro” e a fantasticare di un “umanesimo del lavoro” perfino in ambienti che si dicono antimarxisti.
Un Gentile ha appunto cominciato col glorificare “l’umanesimo della cultura” quale “tappa gloriosa dell’emancipazione dell’uomo” – nel che va intesa la fase liberale, individualistico intellettuale della sovversione mondiale; tappa insufficiente, egli dice, perché “bisognava che si riconoscesse anche al lavoratore l’alta dignità che l’uomo pensando aveva scoperto nel pensiero”.
Così non vi sarebbe “alcun dubbio che i moti sociali e i paralleli moti socialisti del XX secolo abbiano creato un nuovo umanesimo – l’umanesimo del lavoro – la cui instaurazione come attualità e concretezza è l’opera e il compito del nostro secolo”. Il logico sviluppo della deviazione liberale, quale noi l’abbiamo indicato in precedenza, qui appare ben chiaro. Questo “umanesimo del lavoro” fa infatti tutt’uno con l’ “umanesimo integrale” o “realistico” o “nuovo umanesimo” degli intellettuali comunisti[3] e l’ “eticità” e l’ “alta dignità” rivendicate al lavoro sono solo una insulsa funzione a che l’uomo dimentichi ogni interesse superiore ed accetti di buon grado il suo inquadramento ottuso e insensato in strutture barbariche: barbariche, perché non conoscenti altro che lavoro e gerarchie produttive.
Il più singolare è che questo culto superstizioso e insolente del lavoro viene bandito proprio in un’epoca in cui la irrevocabile meccanicizzazione ad oltranza toglie quasi senza residuo alle varietà principali del lavoro (di ciò che può venire legittimamente chiamato lavoro) quel che in esse poteva avere un carattere di qualità, di arte, di esplicazione spontanea di una vocazione, facendone invece qualcosa di disaminato e di privo di ogni significato immanente.
Così coloro che avanzano l’esigenza, giusta, della “sproletarizzazione” si illudono se in ciò vedono solo un problema sociale.
Il compito è anzitutto sproletarizzare la visione della vita, compito non assolvendo il quale tutto resta obliquo e vincolato. Ma lo spirito proletario, la qualità spiritualmente proletaria[4], sussiste quando non si sa concepire un tipo umano più alto di quello del “lavoratore”, quando si fantastica sulla “eticità del lavoro”, quando si inneggia alla “società” o “Stato del lavoro”, quando non si abbia il coraggio di schierarsi decisamente contro tutti questi nuovi miti contaminatori.
Un’antica immagine è quella di un uomo che correndo affannosamente sotto il sole ardente, ad un certo punto si chiede: Ma perché corro? Se andassi più adagio? e andando più adagio, si chiede: Ma perché vado in questa arsura? Se sostassi sotto un albero? e così facendo riconosce come una insensata febbre quel suo correre.
Una immagine del genere indica il cambiamento interno, la metanoia necessaria per colpire alla base la demonìa dell’economia e per riconquistare l’intera libertà: ciò, non certo per passare ad una civiltà rinunciataria, utopica e miserabile, ma per desaturare ogni dominio da tensioni insane e per ripristinare una gerarchia reale di valori. Il punto fondamentale, qui, è appunto il saper riconoscere che non vi è accrescimento esteriore economico e prosperità sociale che vaga la pena e alla cui lusinga non si debba assolutamente resistere quando controparte ne sia una limitazione essenziale della libertà e dello spazio occorrente a che ognuno possa realizzare quel che gli è possibile di là dalla sfera condizionata dalla materia e dai bisogni della vita ordinaria.
Peraltro, ciò vale non solo per il singolo, ma anche per una collettività, per uno Stato, specie ove le risorse materiali di esso siano limitate e su di esso premano forze economiche straniere.
Qui l’autarchia può essere un precetto etico, perché identico deve essere, per un singolo e per uno Stato, ciò che pesa di più, sulla bilancia dei valori: meglio rinunciare alle lusinghe del miglioramento delle condizioni sociali ed economiche generali ed adottare, ove occorra, un regime di austerity, che non aggiogarsi al carro di interessi stranieri, che non lasciarsi coinvolgere in processi mondiali di un’egemonia e di una produttività economiche senza freno destinati a colpire chi li ha scatenati, quando non troveranno più spazio sufficiente.
L’insieme della situazione attuale è naturalmente tale da dare un carattere contro corrente a tutte queste nostre considerazioni. Se ciò non tocca affatto il loro valore intrinseco, tuttavia devesi riconoscere che, praticamente, al singolo oggi non è dato di reagire e di sottrarsi individualmente all’ingranaggio complessivo dell’era economica se non entro limiti ristretti e date certe condizioni più o meno privilegiate.
Un mutamento sensibile generale può attendersi solo quando intervenga un potere sopraordinato. Riconosciuto che sia il principio fondamentale del primato e della sovranità dello Stato rispetto all’economia, dallo Stato può procedere un’azione limitatrice ed ordinatrice nel campo economico, che agevoli quanto può derivare dal fattore essenziale e imprescindibile, costituito, come si è detto, dalla disintossicazione, dal mutamento di mentalità e dal ritorno alla normalità di uomini che conoscano di nuovo ciò che è sensata attività, giusto sforzo, cosa degna di essere perseguita, fedeltà a sé stessi.
“Contestatori” in un senso integrale e legittimo da una parte, “realizzatori” in senso superiore dall’altra, non si può essere che su tale base.
Sui rapporti fra Stato e economia torneremo fra breve.
Qui vogliamo ancora ricordare queste parole di Nietzsche, per mettere le cose a posto e tagliar corto con la cosiddetta “quistione sociale”: “I lavoratori debbono vivere un giorno come oggi vivono i borghesi – ma al disopra di essi, da essi distinguendosi per una mancanza di bisogni, sarà la casta superiore: più povera, più semplice, ma in possesso della potenza”[5].
Una differenziazione in questo senso sarà il principio per la rettificazione dell’inversione da noi accusata, il principio per la difesa dell’idea dello Stato e per il risorgere di dignità e di superiorità che, di là dal mondo dell’economia, attraverso una continua lotta, interna ed esterna, attraverso la conferma del proprio essere mediante una conquista d’ogni momento, debbono venire consolidate e convalidate.
[1] Si può qui ricordare la concezione aristotelica della giustizia sociale, intesa non come distribuzione eguale dei beni, ma come distribuzione proporzionata alla diversa dignità della funzione e della qualificazione dei singoli e dei gruppi giusta disuguaglianza economica.
[2] Su ciò, cfr. W. SOMBART, Il borghese, trad. fr, Paris, 1926, p. 419.
[3] Il Gentile, fra l’altro, ebbe a definire il comunismo come un “corporativismo impaziente”. Ciò equivaleva a dire che fra il corporativismo del periodo fascista quale egli l’interpretava, e il comunismo non vi sarebbe stata nessuna differenza qualitativa, ma solo quella di due tappe e di due tempi sulla stessa direzione.
[4] E’ essenzialmente in questi termini che si deve porre il problema, perché il proletariato sociale nell’antico senso marxismo ormai in Occidente è quasi inesistente: i “lavoratori” già proletari oggi spesso hanno una posizione economica superiore a quella della media borghesia.
[5] F. NIETZSCHE, Wille zur Macht, & 764.
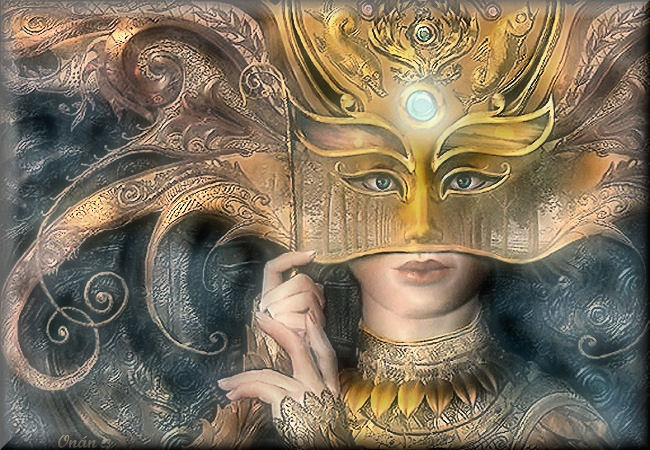






Commenti recenti