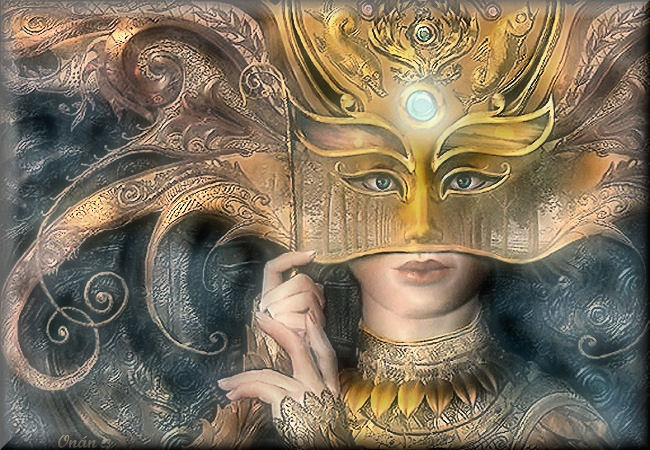Fu Julius Evola a rilevare come anticamente, fin dall’epoca dei Cromagnon, l’arte figurativa fosse sempre stata [1] caratterizzata dall’«inseparabilità dell’elemento naturalistico da una intenzione magico-simbolica». Prendendo le fila da questa osservazione, vi è subito da notare come nel mondo tradizionale l’arte non fu mai considerata fine a se stessa né fondata unicamente su concetti quali esteriori quali bellezza o piacevolezza: al contrario, si può affermare che il fine principale dell’arte figurativa antica – come ad es. nel caso delle pitture rupestri rappresentanti scene di caccia – fu sempre di carattere magico-apotropaico.
In altri termini, tradizionalmente la raffigurazione pittorica ebbe lo scopo di concentrare l’attenzione “magica” dei membri della società tribale, ad es. sulla preda che veniva dipinta. Questa convergenza di attenzione e volontà da parte di tutti i consociati avrebbe condotto al risultato sperato, e veicolato dalla pittura: la cattura della selvaggina. Sempre il filosofo romano fa notare come [2] «le arti antiche … erano tradizionalmente “sacre” a particolari numi o eroi, sempre per ragioni analogiche, tanto da presentarsi come contenenti potenzialmente la possibilità di realizzare “ritualmente”, cioè nel valore di simbolo di una azione o significato trascendente, la varietà dell’azione materiale».
E ciò non vale solo per quanto riguarda la pittura: nell’esempio dei Cromagnon a cui abbiamo accennato, una funzione importantissima ebbe anche la danza rituale. Una visione per così dire complementare del sacro e del profano — per come siamo soliti intenderli noi uomini moderni — sopravvisse a lungo: ancora in epoca classica, Luciano riferisce che i danzatori avevano conoscenza dei “sacri misteri”, ragion per cui non di rado venivano assimilati a dei sacerdoti. Si deve dunque sottolineare come, nelle società tradizionali (e con ciò intendiamo comprendere una fascia temporale della durata di diverse decine di millenni) ad ogni arte o scienza profana è sempre corrisposta una “scienza sacra”, la quale aveva, per dirlo con Evola [3] «un carattere organico-qualitativo e considerante la natura come un tutto, in una gerarchia di gradi di realtà e di forme di esperienza, delle quali forme quella legata ai sensi fisici non è che una particolare». In questo senso Ananda K. Coomaraswamy poté affermare che [4] «religione e arte sono quindi nomi diversi per una stessa esperienza: un’intuizione della realtà e dell’identità».
Identificandosi con le figure non solo antropomorfe della pittura rupestre, ma altresì anche e soprattutto con le rappresentazioni della preda (una renna, per esempio) i cacciatori Cromagnon si assicuravano il buon esito della spedizione: in tale operazione magico-apotropaica era essenziale l’identificazione con la situazione stessa, e quindi con tutti i fattori da cui ne sarebbe dipeso l’esito — i cacciatori così come la preda. Si pensi anche alle prime forme mediterranee delle arti teatrali: da una parte esse avevano relazione con un antichissimo complesso di cerimoniali volti ad ottenere e a garantire la fertilità del mondo naturale (si può pensare a questo riguardo ai rituali del tipo dei Lupercalia, i quali dietro l’aspetto esteriore di pantomime veicolavano una funzione magica ben poco dissimile da quella che sottintendevano le danze e le pitture dei Cromagnon); dall’altra, se sfociarono nei “drammi sacri” del tipo della tragedia (da τραγῳδία, trago(i)día, lett. «canto del capro»), la ragione con tutta probabilità è da ricercarsi nelle loro origini.
Noi riteniamo infatti che il substrato da cui nacque l’ars teatrale mediterranea vada ricercato nell’ambito del Sacro, e segnatamente nelle iniziazioni e nelle adunate delle confraternite misteriche del mondo antico — quali le Dionisie e le Tesmoforie—oltre che nelle mascherate di fine anno e di altre ricorrenze tradizionali del calendario cosmico-agrario.
Lo stesso esoterista francese René Guénon [5] ebbe modo di affermare che «tutte le arti alla loro origine sono essenzialmente simboliche e rituali, ed è soltanto a causa di una degenerazione posteriore, in realtà molto recente, che esse perdono questo loro carattere sacro per diventare alla fine il “gioco” puramente profano a cui si riducono presso i nostri contemporanei».
⁂
Una visione sacrale dell’arte figurativa si trova forse ai suoi livelli più elevati nell’India antica. A riguardo, sono centrali gli studi del già menzionato Coomaraswamy [6], per il quale il solo elemento essenziale dell’arte, nella concezione tradizionale indù, deve rintracciarsi in ciò che gli indiani denominano rasa (“sapore”). Da questo termine deriva l’aggettivo rasavat (“dotato di rasa”), che si dice di quelle opere d’arte (figurative, poetiche, etc.) che si ritengono in grado di suscitare una sensazione di contemplazione estatica che conduce a una sorta di partecipazione e comprensione istantanea da parte dell’osservatore: rāsāsvādava (“assaporamento del rasa”). Colui che di fronte ad un’opera d’arte sia in grado di connettersi con il suo significato più intimo e trascendente viene detto rasika, vale a dire “colui che gode del rasa”. Così scrive lo studioso anglo-cingalese [7]: «L’assaporamento del rasa — la visione della bellezza — è qualcosa che viene goduto, dice Viśvanātha, “soltanto da coloro che ne hanno la competenza”: e cita Dharmadatta, secondo cui “nel teatro coloro che sono privi di immaginazione sono come gli oggetti di legno, i muri e le pietre”».
Una definizione illuminante di cosa sia con esattezza il rasa ci viene data da Viśvanātha nel Sāhitya Darpana: la natura di questa esperienza «è pura, indivisibile, manifesta da sé, composta in parti uguali di gioia e consapevolezza, libera dalla mescolanza con qualunque altra percezione, sorella gemella dell’esperienza mistica, e la sua stessa vita è la meraviglia sovrasensibile». Si tenga conto, come precisa Coomaraswamy [8], che nel pensiero induista la meraviglia è definita come «una sorta di espansione della mente nell’“ammirazione”». Si tratta dunque di una concezione per così dire elitaria della fruizione artistica: ancora più che l’autore della medesima, il quale come sottolinea Coomaraswamy [9] «è assorbito dal suo tema», centrale e fondamentale nell’esperienza della fruizione artistica è il ruolo dell’osservatore, che si presenta in questo senso come vera e propria parte attiva dell’esperienza artistica. Difatti, continua l’Autore [10] l’elaborazione tecnica, il realismo e persino la bellezza in sé non sono cause determinanti del rasa, essendo piuttosto determinante lo stato ricettivo del devoto osservatore. A riprova di ciò, egli cita la massima di Śukrācārya secondo cui «le imperfezioni delle immagini vengono costantemente distrutte dal potere della virtù del devoto che ha il suo cuore sempre rivolto a Dio», vale a dire dalla sua capacità di assaporare il rasa, di connettersi ai livelli più elevati e impersonali della creazione artistica.
La bellezza non esiste senza la percezione: e tuttavia, secondo Coomaraswamy [11], «essa è atemporale e, inoltre, sovrasensibile e trascendente la fisica, e la sola prova della sua realtà va cercata nell’esperienza». Le parole dello studioso anglo-cingalese sono illuminanti anche per quanto riguarda la questione della predominanza dell’opera d’arte, vista come “veicolo” verso il rāsāsvādava, sull’artista stesso [12]: «L’artista tradizionale si dedica in modo incondizionato al bene dell’opera. Il suo fare è un rito, il cui celebrante esprime se stesso in maniera né intenzionale né consapevole. Le opere dell’arte tradizionale, cristiana, orientale o popolare non sono quasi mai contrassegnate da accidenti temporali ma prodotte in armonia con una concezione dominante del significato della vita, il cui obiettivo è ben espresso nell’affermazione di San Paolo, “vivo autem iam non ego”; l’artista è anonimo, e anche quando il suo nome è registrato, ignoriamo quasi tutto dell’uomo. Ciò vale per le opere letterarie come di arte plastica. Nelle arti tradizionali la domanda che conta non è mai: “Chi ha detto?”, ma solo: “Che cosa è stato detto?”, poiché “tutto ciò che è vero, da chiunque sia stato detto, origina nello Spirito”».
⁂
Per comprendere meglio lo “spirito” dell’arte figurativa indiana può essere utile consultare Miti e simboli dell’India dell’orientalista tedesco Heinrich Zimmer, testo che fornisce un’interpretazione e una visione generale dei principali miti e dèi del pantheon induista, con un occhio di riguardo alla dimensione artistica — complice un vasto appendice di fotografie e illustrazioni.
Così, ad es., il bassorilievo raffigurante Indra re degli dèi, assiso sul gigantesco elefante Airāvata (figura 1), localizzato in una grotta-monastero buddhista del II secolo a.C. presso Bhājā, fornisce a Zimmer l’occasione di esporre la rappresentazione della concezione induista di Māyā nell’arte figurativa [13]: «Le figure emergono dalla roccia e ne ricoprono la superficie in sottili strati ondulati, simili a increspature di una sostanza nebulosa, cosicché, sebbene scolpite nella roccia viva, danno l’impressione di una sorta di miraggio. La sostanza della pietra sembra aver assunto i contorni vagamente evanescenti di un’emanazione. È come se la roccia anonima, informe e indifferenziata fosse in procinto di trasformarsi in forme individualizzate e animate. L’idea fondamentale della māyā si trova così riflessa in questo stile. Esso rappresenta l’apparire di forme viventi da un’informe sostanza originaria; illustra il carattere fenomenico, simile a un miraggio, di ogni esistenza, terrena o divina».

Figura 1 – Indra re degli dèi, assiso sul gigantesco elefante Airāvata – Bhājā, India
La medesima tecnica figurativa si può ritrovare nel bassorilievo, eseguito direttamente nella nuda roccia presso Māmallapuram, raffigurante la “discesa celeste del Gange” (figura 2), datato all’inizio del VII secolo d.C. Le figure, sebbene differenziate e caratterizzate, non sono definite nei minimi particolari, bensì appaiono piuttosto come proveniente da un’unica fonte, il Gange celeste appunto, immagine della perenne (fonte di) creazione divina, da cui traggono vita e forma. Rileva Zimmer [14]: «Trascurando i tratti e i dettagli minuti, quest’opera d’arte mira a rendere gli atteggiamenti, i movimenti tipici o le posizioni di riposo degli esseri che raffigura. Insiste sull’affinità fondamentale di tutte le creature. Tutte hanno origine da quell’unico serbatoio di vita e vengono tenute in vita sui loro diversi piani, celesti o terreni, da quell’unica energia vitale. Questa è un’arte ispirata dalla visione monistica della vita che appare ovunque nella filosofia e nel mito indù. Ogni cosa è viva. L’intero universo è vivo: variano solo i gradi della vita. Ogni cosa procede dalla divina sostanza-e-energia-vitale come una trasformazione temporanea. Tutto fa parte dello spiegamento universale della māyā di Dio».

Figura 2 – La “discesa celeste del Gange” – inizio del VII secolo d.C. – Mamallapuram
⁂
Dopo aver speso molte parole sull’opera d’arte in sé e sul ruolo dell’osservatore, sarà bene ora dire qualcosa anche sul ruolo tradizionale dell’artista. Si potrebbe cominciare col dire che colui il quale, mediante il suo lavoro, sia in grado di conferire un significato superiore alla materia è paragonabile all’eroe che si addentra nel mondo infero, “fondo originario” jüngeriano di tutte le cose: la “fonte del Gange celeste”.
Come un novello Orfeo, l’artista compie una catabasi dentro i recessi della sua coscienza, per risalire poi trasformato, in seguito a una rivelazione che egli tenterà di rappresentare in modo figurativo. La trasformazione della materia che ne consegue sarà — appunto — solo una conseguenza della sua esperienza primaria, ma fungerà anche da veicolo attraverso il quale altri potranno sperimentare la medesima esperienza sacrale.
In questo senso Mircea Eliade rilevò come [15] «… l’artista non si comporta in maniera passiva nei riguardi del Cosmo né verso l’inconscio. Senza dircelo, forse senza saperlo, l’artista penetra, talvolta pericolosamente, nelle profondità del mondo e della propria psiche … assistiamo a uno sforzo disperato dell’artista per liberarsi della “superficie” delle cose e penetrare nella materia allo scopo di svelarne le strutture ultime. Abolire le forme e i volumi, discendere all’interno della sostanza, svelarne le modalità segrete o larvali non sono, per l’artista, delle operazioni intraprese in vista di una conoscenza obiettiva, ma delle avventure provocate dal suo desiderio di cogliere il senso profondo del suo universo plastico».
Da questa prospettiva, si potrebbe affermare che l’artista che sappia compiere questa descensus ad infera oltre che ad un novello Orfeo sia anche paragonabile a un alchimista, ossessionato dal mistero della trasmutazione della materia grezza in oro, o a uno sciamano in trance estatica, vagabondo attraverso i molteplici livelli dell’essere. Certo concordiamo con Eliade, quando afferma che [16] «in certi casi, il comportamento dell’artista verso la materia ritrova e ricupera una religiosità di tipo estremamente arcaico, scomparsa da millenni nel mondo occidentale … La ierofanizzazione della materia, cioè la scoperta del sacro manifestato attraverso la sostanza, caratterizza ciò che si chiama la “religiosità cosmica”, il tipo di esperienza religiosa che ha dominato il mondo fino al giudaismo e che è ancora vivo nelle società “primitive” e asiatiche».
Tramite tale sacralizzazione della sostanza, l’artista ha la possibilità di tramutare alchemicamente la nuda materia grezza in qualcosa dotato di una forma che prima che essere fisica è innanzitutto ideale, visualizzata ed anzi esperita ad un livello per così dire “sottile”. Tale forma infatti altro non è se non l’esteriorizzazione di una esperienza avuta in altri reami, che l’artista in questo piano della realtà tenta arditamente di imprimere sulla materia, conferendole una forma. Chi sappia compiere ciò, in ultima analisi, vive lui stesso indubbiamente un’esperienza di rāsāsvādava durante la creazione stessa dell’opera artistica, fase ultima del procedimento creativo per il cui tramite chiunque sia in grado di connettersi allo stesso livello a cui è asceso l’artista nel momento della creazione avrà anche l’opportunità di sperimentare la medesima esperienza sacrale.
In questo senso, l’opera d’arte tradizionalmente fu una sorta di portale per l’ascensione a livelli più puri ed elevati, e certamente sovrapersonali, di coscienza: e ciò — come abbiamo visto — sia per l’osservatore che per l’artista. E ciò non vale solo per quanto riguarda l’arte pittorica o statuaria, ma anche per quella architettonica. Come ebbe modo di rilevare Ernst Jünger nel suo diario [17] (agosto 1965), meditando sul “celarsi del divino” e sulla funzione dei templi nel mondo odierno, «non è tanto l’incontro con gli dèi a contare, ma ciò che si concentra in loro o dietro di loro. Gli antenati dello scintoismo sono lì, sui dipinti o sulle tavolette; l’aspetto e il nome si fondono: il cammino che spalancano conduce ad ampissime distanze. È solo a quel punto che risulta indifferente il fatto che ci si trovi di fronte a una fotografia, a un’incisione qualsiasi o a un capolavoro. I templi sono portali e accessi».
Marco Maculotti
[1] Julius Evola, Rivolta contro il mondo moderno (Mediterranee, Roma, 1984), p. 136.
[2] Ibidem, p. 137.
[3] Ibidem, p. 134.
[4] Ananda K. Coomaraswamy, La danza di Śiva (Adelphi, Milano, 2011), p. 71.
[5] René Guénon, Il regno della quantità e il segno dei tempi, p. 179.
[6] Ananda K. Coomaraswamy, La danza di Śiva (Adelphi, Milano, 2011), p. 62.
[7] Ibidem, p. 66.
[8] Ibidem, p. 70, nota 4.
[9] Ibidem, p. 54.
[10] Ibidem, pp. 67-68.
[11] Ibidem, p. 71.
[12] Ananda K. Coomaraswamy, “Verità e universalità della filosofia cristiana e orientale dell’arte”, in La filosofia dell’arte cristiana e orientale (Abscondita, Milano, 2005), p. 47.
[13] Heinrich Zimmer, Miti e simboli dell’India (Adelphi, Milano, 2012), p. 57.
[14] Ibidem, p. 111.
[15] Mircea Eliade, “La permanenza del sacro nell’arte contemporanea”, in Spezzare il tetto della casa. La creatività e i suoi simboli (Jaca Book, Milano, 2016), p. 21.
[16] Ibidem.
[17] Ernst Jünger, Siebzig verweht (Klett-Cotta, Stuttgart, 1980). Traduzione di Andrea Scarabelli.
Courtesy of Daily Alchemist Magazine